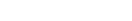Il baccalà, come lo chiamiamo in Veneto, quello che mangiamo nelle nostre tavole sia mantecato, che in umido che alla vicentina è legato alla storia di Querini, senatore della Repubblica di Venezia, che lo portò dal Nord Europa fino alla città di Venezia.
Il nobile Piero Querini, mercante veneziano, nel 1431 cercava fortune commerciali fuori dal Mediterraneo. Partito da Candia (isola di Creta colonia della Serenissima) con una nave carica di malvasia, legni aromatici, spezie e cotone con l’intento di raggiungere le Fiandre, vide via via svanire il suo sogno commerciale che terminò con un tragico naufragio.
Infatti si trovava al largo dell’Arcipelago di Lofoten, che veleggiava coi suoi sessantotto marinaie, all’improvviso, si scatenò una tempesta. La nave era ingovernabile, il vento soffiava forte e il mare era grosso tanto da mettere a rischio sia il mercantile che il suo equipaggio. Il capitano Querini fu l’ultimo ad abbandonare la sua imbarcazione a bordo di una delle due scialuppe. Parte dell’equipaggio perì tra i flutti, ma una delle due imbarcazioni di salvataggio, in balìa dei marosi e dei capricci dei venti, raggiunse fortunosamente un isolotto, coperto di neve: era l’isola di Roest. Riuscirono a sopravvivere bevendo neve sciolta e nutrendosi con frutti di mare e molluschi strappati all’oceano, fino a che, approdarono sullo scoglio gli abitanti di un’altra isola vicina. I poveri superstiti vennero da loro accolti, nutriti e curati.
Questa gente aveva come alimento principale il merluzzo e Querini, quale scaltro mercante, notò immediatamente che gli abitanti si nutrivano con questo pesce a lui poco noto, sia fresco che salato, oppure essiccato e battuto al pallido sole artico. Incuriosito ed affascinato da questo animale e dal suo metodo di conservazione, Querini decise di ripartire per Venezia con un grande carico di queste pesce essicato duro come il legno, che per essere consumato deve essere battuto con il roverso (legno). Il mercante veneziano tornò a casa dopo un lungo viaggio per mare e per terra e portò con sé il nuovo curioso alimento, scambiandolo lungo il tragitto fino a Venezia, con vitto, alloggio e trasporti di vario genere.
La gente di là chiamava questo cibo “Stockfiss”. Il termine “stoccafisso” deriva dall’olandese stokvisch (stock = bastone e visch = pesce), ovvero pesce essiccato sul bastone. Assai più incerta è invece l’origine del termine “baccalà” che in Veneto e Friuli è sinonimo di stoccafisso, ovvero merluzzo essiccato, mentre nel resto dell’Italia significa merluzzo salato. Se l’origine della parola stoccafisso è chiara, quella di baccalà, preferita dai veneti, non lo è.
La teoria maggiormente accreditata fa derivare la parola dal portoghese bacalhau e dallo spagnolo bacalao, termini che trovano la loro etimologia nel latino baculus, bastone usata dal 1500.
Più di un secolo dopo, e precisamente durante il Concilio di Trento del 1563, venne sancito l’obbligo di astinenza dalla carne per duecento giorni e raccomandato come piatto di magro il mercoledì e il venerdì proprio lo stoccafisso. Questo pesce ebbe un ruolo salvifico nelle mense della popolazione meno abbiente vessata dalle intransigenti regole alimentari imposte dalla Riforma. Piatto popolare e conservabile, di larga resa e costo contenuto. È proprio, in questo periodo, che il merluzzo nordico viene consacrato a piatto della cucina italiana dal cuoco Bartolomeo Scappi, che lo inserisce all’interno del suo ricettario.
Ecco la ricetta originale del Baccalà mantecato
Baccalà mantecatoIngredienti per preparare il Baccalà mantecato per quattro persone:
300 g di baccalà (o stoccafisso) già bagnato e deliscato
0,3 L di olio extra vergine
1 spicchio d’aglio
Alloro, Limone, Sale, Pepe
Mettete il baccalà in una pentola capiente e copritelo con acqua fredda leggermente salata, avendo cura di aggiungere l’aglio, il succo del limone e l’alloro. Raggiunto il bollore, schiumate.
Cuocete il baccalà per circa 20 minuti. Quindi, mantecate la polpa del pesce a mano con un cucchiaio di legno o con una planetaria, versando a filo l’olio e lasciando montare come se fosse una maionese, fino ad ottenere una crema compatta ed omogenea. Se fosse troppo lucido aggiungete un po’ di acqua di cottura. Finite la mantecatura con ancora qualche pezzo intero. Aggiustate di sale e di pepe. Servitelo guarnendo con un trito di prezzemolo fresco e accompagnandolo con la polenta grigliata.
Anche se la ricetta originale non lo prevede, potete aggiungere un po’ di latte per rendere il vostro baccalà mantecato più delicato e spumoso.
La “Venerabile Confraternita del bacalà alla vicentina” suggerisce una ricetta che è il frutto di studi e di comparazioni tra le numerose ricette in auge nei ristoranti e nelle trattorie più famose del Vicentino tra gli anni trenta e cinquanta senza demonizzare le varianti attualmente in servizio.
Ingredienti per 12 persone:
Kg 1 di stoccafisso secco – gr. 250/300 di cipolle
1/2 litro di olio d’oliva extravergine
3 sarde sotto sale
½ litro di latte fresco – poca farina bianca
- 50 di formaggio grana grattugiato
un ciuffo di prezzemolo tritato
sale e pepe
Preparazione
Ammollare lo stoccafisso, già ben battuto, in acqua fredda, cambiandola ogni 4 ore, per 2-3 giorni.
Aprire il pesce per lungo, togliere la lisca e tutte le spine. Tagliarlo a pezzi.
Affettare finemente le cipolle; rosolarle in un tegamino con un bicchiere d’olio, aggiungere le sarde sotto sale, e tagliate a pezzetti; per ultimo, a fuoco spento, unire il prezzemolo tritato.
Infarinare i vari pezzi di stoccafisso, irrorati con il soffritto preparato, poi disporli uno accanto all’altro, in un tegame di cotto o alluminio oppure in una pirofila (sul cui fondo si sara’ versata, prima, qualche cucchiaiata di soffritto); ricoprire il pesce con il resto del soffritto, aggiungendo anche il latte, il grana grattugiato, il sale, il pepe.
Unire l’olio fino a ricoprire tutti i pezzi, livellandoli.
Cuocere a fuoco molto dolce per circa 4 ore e mezzo, muovendo ogni tanto il recipiente in senso rotatorio, senza mai mescolare.
Questa fase di cottura, in termine “vicentino” si chiama “pipare”.
Solamente l’esperienza saprà definire l’esatta cottura dello stoccafisso che, da esemplare ad esemplare, può differire di consistenza.
Il bacalà alla vicentina è ottimo anche dopo un riposo di 12/24 ore. Servire con polenta.
Alberta Bellussi
 Questo dolce-biscotto è per tradizione preparato a Venezia ma ormai la consuetudine si è estesa in tutto il Veneto dove questi simpatici cavalli vengono esposti in bella mostra nelle vetrine di numerose pasticcerie. E’ un dolce molto apprezzato dai bambini,
Questo dolce-biscotto è per tradizione preparato a Venezia ma ormai la consuetudine si è estesa in tutto il Veneto dove questi simpatici cavalli vengono esposti in bella mostra nelle vetrine di numerose pasticcerie. E’ un dolce molto apprezzato dai bambini,