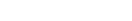Andémo béver un’ombra in un bàcaro
Quante volte si sente dire : “Ciò, Andémo béver un’ombra!”…
E’ questo un invito conviviale molto usato in Veneto e si tramanda da generazioni. Davanti a un “ombra” cioè a un bicchiere di vino si fanno quattro chiacchiere con gli amici, si concludono affari, ci si rilassa per spezzare la giornata.
Ma da dove deriva questa espressione?
Il termine risale alla fine del secolo quattordicesimo quando, attorno al campanile di S. Marco, venivano montate molte bancarelle di legno che proponevano varie attività commerciali: rigattieri, panettieri, spezieri e osterie. La Piazza era infatti il luogo ideale per incontri e chiacchiere, solitamente accompagnate da un buon bicchiere di vino. I mescitori di vino avevano molto lavoro; loro per non rovinare il prezioso liquido di Bacco e mantenerlo sempre fresco anche nelle stagioni più calde, spostavano la loro bancarella attorno al Campanile, inseguendo la sua ombra man mano che si spostava il sole. Il vino, per essere buono, doveva rimanere all’ombra e così il bicchiere di vino prese il nome … l’ombra.
Un’altra spiegazione simile nel contenuto ma diversa nella contestualizzazione poggia le sue basi nella civiltà contadina. Tempo fa i contadini al momento della mietitura si alzavano molto presto e verso le 9/10 erano 4/5 ore che lavoravano di falce, il sole a picco …..a quell’ora le donne portavano la merenda ( polenta e ….poco altro).
Ecco che allora si disse :
‘Ndemo farse un ombra…vale a dire : andiamo all’ombra di un albero e bere un bicchiere di vino e a mangiare. Cit Marino Panto
Un tempo si diceva: “Andémo béver all’ombra”, che con la trasmissione orale divenne : “Andémo béver un’ombra”. Questo modo di dire è tutt’ora molto vivo e molto usato in tutto il Veneto.
E “l’ombra” a Venezia si beve nel bàcaro.
L’etimologia dell’appellativo bàcaro è alquanto controversa, nel corso degli anni, infatti, si sono affermate 4 teorie sulla sua origine:
- secondo la prima il termine bàcaro deriva dal nome del dio romano del vino e della vendemmia: Bacco;
- una seconda teoria fa desumere il nome dalla tipica espressione veneziana “far bàcara“, che letteralmente significa “far festa”; si fa risalire, infatti, a una esclamazione di un gondoliere che un giorno, assaggiando un nuovo vino venuto dal sud Italia, esclamò: Bon, bon! Questo xe proprio un “vin de bàcaro”. L’espressione veneziana “far bàcara” equivale a far baldoria, mangiare e bere in buona compagnia: quindi un “vin de bàcaro” non può essere che un vino adatto a questo scopo. Secondo questa leggenda, riportata da Elio Zorzi nel suo libro “Osterie Veneziane´ del 1928, il gondoliere avrebbe creato un nuovo termine, che si trasmise poi ai locali di mescita di vino sfuso;
- bàcari pare che venissero chiamati anche i venditori di vino in botte a Piazza San Marco;
- l’ipotesi meno probabile è quella che il nome derivi da un vino pugliese del ‘700 particolarmente apprezzato nella città, vino appunto chiamato bàcaro.
Alberta Bellussi
- 29 October 2017
- 1 Comment