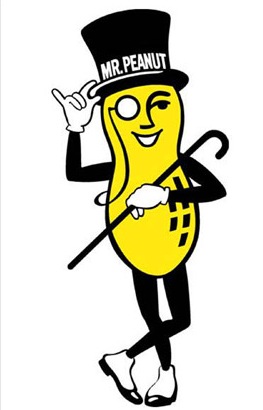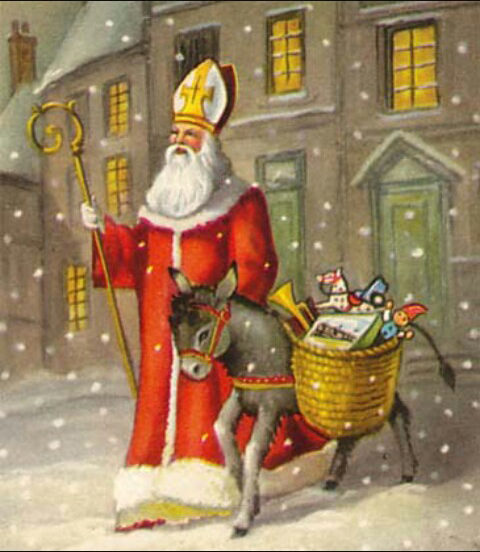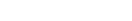La chiocciola, @, è un carattere apparso, insistentemente, nella nostra vita negli ultimi 20 anni. E’ simpatico nel nome, quasi amichevole e fumettistico nella sua rappresentazione grafica.
Ognuno di noi ha un indirizzo mail e quindi ha la sua chiocciolina personale. Non c’è tastiera del Pc che non abbia questo simbolo ma appare dalla combinazione con l’Alt-Gr. Anche sui social network la chiocciola è diventata utile, per i tag, ovvero per far sapere ad una persona che stiamo parlando di lei, per un uso molto comune di questo simbolo.
La usa un numero smisurato di persone ma credo che pochi sappiano che, in realtà, la chiocciola, detta anche “a commerciale”, ha origini molto, molto più lontane di quello che possiamo immaginare.
La sua storia poggia le basi nella Venezia del pieno medioevo, nel VI secolo d.C., quando l’Impero Romano d’occidente già era caduto ma quello d’oriente ancora era ben saldo. In questo quadro economico Venezia si confermava come una vera e propria capitale dei commerci. La città veneta aveva un ruolo così importante e predominante che si permetteva il lusso di crearsi unità di misura inventate per rendere più equi possibili gli atti di compravendita.
In questo contesto venne inventata la chiocciola. Il simbolo trae origine dal simbolo à, con l’accento che è stato man mano allungato fino ad essere portato come lo conosciamo oggi nella @, soprattutto per una questione di distinzione grafica tra i simboli.
In realtà graficamente simboleggiava l’anfora, che nei tempi antichi era utilizzata come unità di misura di peso o di capacità a seconda se c’erano all’interno dei solidi o dei liquidi. Le anfore erano considerate un’unità di misura universale, e la chiocciola in questa connotazione fu utilizzata per moltissimi anni, nei commerci.
Nei tempi moderni il simbolo non perse la sua valenza commerciale. In uno dei primi modelli di macchina per scrivere la chiocciola venne utilizzata con il significato di “al prezzo di”, quindi ad esempio “2 chili @ 30 dollari”, per risparmiare inchiostro.
Quando nacquero i primi computer che riprendevano la struttura della tastiera proprio dalla macchina il simbolo fu traslato anche sulla tastiera dei dispositivi più moderni.
La vera entrata trionfale da star nella nostra vita la @ chiocciola la fece nel 1971 quando fu inventata la posta elettronica. L’ingegnere statunitense Raymond Samuel “Ray” Tomlinson di Arpanet responsabile della sua creazione pensò di utilizzare la chiocciola con il significato di “A”, preposizione, per indicare il server a cui il messaggio doveva arrivare. Per esempio, pippo @ server1 significava che il messaggio doveva arrivare a Pippo che si serviva del server1 per leggere la posta. Oggi utilizziamo lo stesso principio infatti ciò che sta dopo la chiocciola è proprio il server, colui che memorizza in uno spazio proprietario i nostri messaggi di posta elettronica, per cui il suo utilizzo, negli ultimi anni, non è mai cambiato.
E’ romantico pensare che questo simbolo @ che lo associamo al massimo della modernità, in quanto ci permette di avere corrispondenza in tutto il mondo in tempo reale, rappresenti da secoli l’anfora antica unità di misura concreta e tangibile.
Il fascino della storia sta proprio in queste piccole curiosità che ritroviamo poi nella nostra quotidianità spesso ignari della loro provenienza.
Alberta Bellussi
- 27 March 2018
- No Comments
- #chiocciola #Venezia #