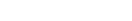Una mia amica mi ha fatto scoprire un dolce di cui non conoscevo l’esistenza la Zonclada; era una torta di origine medioevale tipica della zona di Treviso da essere considerata così prelibata da essere offerta anche a personalità importanti. Nel 1317 furono preparate per Cangrande della Scala. Questo dolce per molti anni scomparve dalle tavole dei trevigiani ma ora qualche pasticceria ne sta riproponendo la ricetta. L’etimologia del nome di questa torta ha molti rimandi storici ma non si sa bene, in realtà, quale sia il più verosimile. La parola è affine al latino iuncus, giunco o a giuncata che è un formaggio fresco la cui cagliata veniva adagiata a spurgare in stuoie fatte appunto di giunchi, di cui ne riprende anche il colore pallido. Ancora altri scritti riportano che il nome Zonclada si deve far risalire alla parola ancora in uso nelle nostre campagne, “zanzega”, che è la festa che fanno i muratori quando la costruzione della casa arriva al coperto e espongono un ramo di foglie sul camino: far zanzega” ovvero far baldoria, rallegrarsi. O potrebbe derivare anche dal dialetto “zoncar” col significato di troncare, e “zontar”, ovvero unire e aggiungere, facendo riferimento al procedimento di preparazione che prevede vari ingredienti tritati mescolati assieme. L’esistenza della Zonclada, in epoca medioevale, ne troviamo conferma “Capitolato del Duomo” di Treviso (1300-1400) e negli “Statuti della città di Treviso” del 1313, dove c’è una prescrizione su come deve essere preparata e sul peso che deve avere, con una pena pecuniaria a chi non dovesse rispettare le disposizioni. Dai racconti delle persone anziane delle nostre campagne trevigiane emerge che si preparava un dolce di nome Zonclada, confezionato come una pinza utilizzando tutte gli ingredienti che avevano a disposizione.
Ingredienti per la pasta frolla
(che potete anche comprare già fatta al supermercato)
- 300 gr di farina
• 120 gr di strutto o margarina
• 100 gr di zucchero
• 1 uovo
• 1 pizzico di sale
• 1 pizzico di cannella
Ingredienti per il ripieno
- 20 gr farina 00
• 500 gr di ricotta
• 2 uova
• 40 gr di burro fuso
• 100 gr di zucchero semolato
• 50 gr di uvetta sultanina
• 50 gr di cedro candito
• 1 cucchiaino di cannella in polvere
Preparazione
Fare ammorbidire l’uvetta sultanina in una ciotolina d’acqua. Tagliare il cedro candito a cubetti molto piccoli. In una ciotola riunire 500 gr di ricotta con 2 uova, il burro fuso, lo zucchero semolato, l’uvetta sultanina, il cedro candito a cubettini e un cucchiaino di cannella.
Mescolare gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo.
Cospargere il panetto di frolla con un po’ di farina, stenderlo con il mattarello sul piano di lavoro a uno spessore di 4-5 mm e incidete un disco di 28-29 cm. Ricavare dai ritagli tante listarelle della larghezza di 1 cm con la rotella dentellata.
Foderare la tortiera antiaderente di 24 cm con il disco di pastafrolla, riempirlo con il composto di ricotta preparato. È possibile coprire lo stampo di pastafrolla con listarelle, tipo crostata, o con un disco di pastafrolla, con dei tagli praticati con un bicchierino di rum e con una rapatura di limone o di arancia. Cuocere la Zonclada nel forno caldo a 180° per circa 30 minuti. Servire tiepido o freddo, a seconda dei gusti.
Buona degustazione!
Alberta Bellussi
- 13 March 2025
- No Comments
- 0