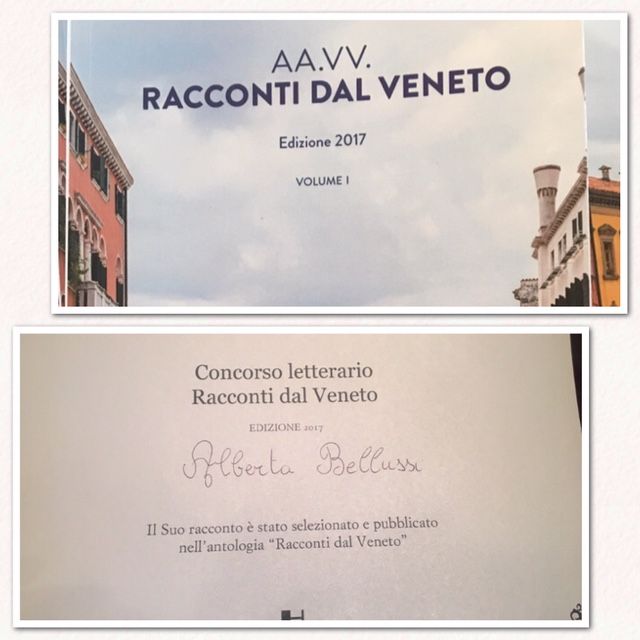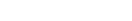“Buongiorno un caffè corretto grazie!”
“Quant’è?”
“Un euro Ioanina come sempre”.
E la Ioanina tira fuori dalla sua borsa “magica” la carta di una caramella tutta piegata e mi paga.
Faccio un sorriso, come ogni giorno, e ritiro “ quei soldi” del caffè. Eh sì! E’ proprio così la Ionanina è piena di carte che per lei sono miliardi. Lei è un’esile vecchietta molto bizzarra “nel suo che”. Indossa abiti un pò lisi, porta sempre gli orecchini e si mette il rossetto un po’ sulle labbra e un pò sulla dentiera ma si capisce che era una donna di classe. Vive nella Casa di Riposo del paese ma scappa via, spesso, a bordo della sua storica bicicletta. Tutte le mattine arriva al bar per il caffè e per raccontare le storie del suo passato. Sì, perché, il racconto del mattino per lei è, ormai, un bisogno a cui non può rinunciare.
Il bar del paese per la “signora” come ama definirsi, è un po’ come la sua casa, che non ha più, e i clienti: i suoi parenti. Lì si sente protetta e al sicuro. Quando inizia a parlare di sé, anche i muri potrebbero continuare quel racconto. I clienti del bar l’hanno sentito milioni di volte, ma nessuno interrompe Ioanina.
Lei conosce tutti quelli che frequentano il bar, tutti la salutano con un sorriso, e le prestano “un orecchio” per qualche minuto. Ognuno fa un piccolo turno di ascolto e lei è felice, si sente importante. Un tempo, la signora Ioanina era una nobildonna di famiglia ricca; almeno così lei racconta.
Poi apre la sua borsetta da cui non si separa mai. E’ una borsetta magica perché è piena di miliardi. Inizia a tirar fuori tutto quello che contiene e a contare le sue piccole e grandi carte: no scusate, non carte ma soldi, lei vede. Cento, duecento, trecento insomma nella sua borsa sono contenuti milioni di lire. Lire, per lei sono rimaste le lire. Non è facile spiegare a una bizzarra anziana di 93 anni che le lire sono sparite perché si rischia di non uscirne fuori. In fondo che le sue carte siano soldi è stato accettato da tutti. E’ curioso che i cosiddetti “normali” abbiano accreditato la sua follia. Gli esercenti del paese accettano, a pagamento dei piccoli acquisti della Ionania, quegli insoliti “soldi”. Lei non ha grandi esigenze: caffè corretto, qualche bicchierino di vov o punch, qualche giornale. Lei è convinta di essere molto ricca e che, come nobildonna, deve essere trattata con riguardo.
Quando siamo soli io e lei, allora, si mette a piangere e mi dice quanto fosse bello quel militare che le aveva rubato il cuore. Parla di questo amore come se fosse ancora vivo. Quando racconta i piccoli occhi verdi, secchi dall’età, d’improvviso si inumidiscono e si emozionano. Suo padre era severo e geloso della figlia e non voleva assolutamente che la “sua principessa” finisse tra le braccia di quell’umile fante di campagna. Era bello, moro…insomma un fusto, il suo militare.
Si è fatto mezzogiorno in Casa di Riposo si mangia a quest’ora.
“Ioanina ti conviene andare sennò salti il pranzo”.
Attratta dal richiamo del cibo lei sale in sella alla sua bicicletta e intanto si asciuga l’ultima lacrima. Una lacrima che evoca la sofferenza di una vita per quell’amore negato sul quale lei ha immaginato racconti romanzati, ha riposto sogni e aspettative e si è sentita, un giorno, donna desiderata.
Accenna la prima pedalata mentre il suo volto torna malinconico alla triste realtà.
“Ciao Ioanina a domani”.
La giornata continua ognuno va per la sua strada, ma il bar del paese rimane sempre un punto fermo.
Il bar della Piazza del paese è un po’ il punto di ritrovo delle persone più fragili della comunità e anche di quelle più sole. Si trovano bene in questo posto perché si sentono protette. In fondo la comunità si prende cura di loro perché proprio per quella bizzarra follia che li distingue sono persone che lasciano il segno e verso cui provi simpatia e tenerezza.
Accade così che “i normali” si trovino quotidianamente a essere catapultati dentro le stranezze “dei diversi” e le assecondino come in un patto segreto. Una realtà nuova che fa entrare “i normali” per qualche momento nel mondo “dei diversi”. Quasi una surreale commedia umana della vita dove cadono maschere, muri e ipocrisie.
Nel pomeriggio è solito passare per il paese un personaggio strano che sembra uscito da un tempo remoto… l’è el vecio dee scoaze che passa con il suo carretto di legno trascinato da Furia un vecchio e stanco equino nero. Urla al suo passaggio: “ Carta, straze e fero vecio”. Al vecchio potrebbero attribuirgli il premio per essere uno dei primi in assoluto ad aver capito l’importanza della raccolta differenziata. Nel suo carretto, da anni e anni, raccoglie rifiuti di qualsiasi tipo e li differenzia…carta, plastica, vetro e qualsiasi altra cosa di cui ci si voglia liberare. Addirittura quando il cavallo esercita i suoi bisogni fisiologici, il vecchio si ferma, e li raccoglie per usarli come fertilizzante per il suo orto. Tutti sanno quando passa e se hanno qualcosa lo mettono fuori del cancello e lui carica e differenzia. A el vecio dee scoaze non interessa molto parlare di lui; ha sguardo serio e concentrato sulla sua raccolta. Porta, in tutte le stagioni, un capello di panno in testa e non accenna mai un sorriso. L’unica creatura alla quale si rivolge con un po’ più d’amore è il suo vecchio e fidato cavallo Furia; è un’intesa di quelle che dura da una vita, costruita giorno dopo giorno. Periodicamente il vecchio passa davanti al bar. Arresta il suo cavallo e aspetta il bicchiere di acqua e menta che le offro nelle giornate afose d’estate. Anche lui, con le sue scandite abitudini, è parte della comunità e anche lui è stato regalato quell’abbraccio che alla fine riscalda e protegge. Un calore umano tipico dei piccoli paesi. Paesi che hanno una strana personalità; abitanti critici e pettegoli sulle cose altrui; spietatamente maldicenti, curiosi e bramosi di riportare la notizia del momento con creativa ricchezza di particolari, anche molto coloriti e ingigantiti, ma dall’altro canto sanno diventare profondamente umani e protettivi con le persone fragili, indifese e bisognose di sostegno.
Mi giro e butto lo sguardo fuori dalla grande vetrata del bar. Vedo catapultarsi, in un gesto simil-eroico, dentro un auto, con il finestrino aperto, il mio caro amico Gino Bicicletta. Lui si sente uno dei protagonisti del telefilm Hazzard, ma non si sa bene quale. Queste incursioni eroiche ogni tanto hanno buon esito e contribuiscono ad aumentano il suo ego da eroe. Fa tutto questo perché poi entra al bar e racconta la sua epica avventura come fosse la vittoria alle Termopili. Accade spesso che queste incursioni non riescano e il bar diventa, allora, il luogo delle medicazioni. Ma il lietmotive della vita di Gino sono sempre le biciclette. Lui le ruba da tutta una vita e poi le nasconde dentro a casa sua. E’ un tipo molto solare e leggero il Gino. Veste camicia attillata a quadretti e braghe jeans a zampa di elefante. Pettina i capelli come John Travolta ed è costretto a mettersi il gel perché la sua brillantina Linetti non la trova più in commercio. Per lui gli anni migliori sono stati gli anni ’60.
Quando cammina dondola un po’ e ti saluta con “UAU”.
Ma tornando alle biciclette, Gino le porta a casa sua che ne è invasa in ogni stanza. Quando la casa è proprio satura le parcheggia nel campo di mais del vicino che usa come deposito. Il problema vero si presenta nel momento della trebbiatura perché la trebbia spesso è bloccata dalla presenza delle biciclette.
La cosa più simpatica, anzi surreale, di Gino bicicletta è che, poi, lui ti rivende la bicicletta che ti ha rubato magari avendole cambiato il colore. Se trovi la tua bicicletta in mezzo a quel campo recupero devi iniziare la trattativa se vuoi riaverla. Gino ha l’occhio furbo, dell’affarista e se vede che ti interessa davvero, alza il prezzo, in un guizzo quasi da Wall Street, ma alla fine con 30/40 euro te la cavi e se ti trova al bar ti paga anche da bere per suggellare l’affare.
Mentre fuori accade tutto ciò, io sono dietro il bancone del bar e dall’altra parte arrivano Bepy e Piero. Ascolto i loro discorsi in disparte e sorrido da solo. Penso quanto sono belli questi personaggi spogliati di ogni filtro ipocrita e liberi di essere ciò che veramente sono. Sono felici di essere liberi e di essere “folli”. Sono quei personaggi che la società moderna convenzionalmente definisce con una parola inglese “border line” cioè persone ai bordi. Io invece le definirei persone che lasciano il segno. Quanto sterile e insignificante sarebbe il mio bar senza la loro quotidiana e ingombrante, ma vivace e simpatica presenza.
Bepy tutto emozionato racconta che l’altra sera nel campo davanti a casa sua è atterrata una grandissima astronave aliena. Siccome lui possiede molte abilità da meccanico, il pilota dell’astronave gli ha suonato il campanello e gli ha chiesto se poteva sostituire loro un bullone. Bepy si è infilato il “tony” per non sporcarsi e ha sostituito il pezzo che faceva 20 metri di circonferenza. Piero lo ascolta, ma non gli da grandi soddisfazioni, gli sembra un’impresa normale; niente di che. Lui racconta di aver girato più volte il globo terracqueo a bordo di navi mercantili. Piero dice a Bepy “ a mi el me par grando sto bueon par una astronave, ma no dise niet pol esser si”. E poi chiede ancora: “ ma ei restadi contenti del lavoro?”
E’ stato un duro lavoro, racconta Bepy, però gli alieni gli hanno dato grandi soddisfazioni e gli hanno anche fatto fare un giro di prova per verificare la solidità del pezzo cambiato.
Piero, che gli secca essere messo in secondo piano, incalza raccontando di quella volta in cui tutta la ciurma della nave era sbronza e lui ha dovuto prendere la guida del timone per far attraccare la nave al porto. La velocità di avvicinamento era troppo elevata e la nave si è fermata dentro la banchina facendo molti danni, ma lui racconta di aver portato tutti a terra sani e salvi come un grande eroe degno di onorificenze pubbliche. Bepy vorrebbe continuare a dire la sua sugli alieni, anche perché gli sembra una cosa degna di grandi attenzioni, ma Piero non lo bada e continua. Era andato a cena con Kennedy al Collegio di Treviso ma non ricordava bene in occasione di cosa. Non fa neanche a tempo di finire questo racconto che gli viene subito alla mente quella notte nell’Hotel di Londra dove Freddy Mercury, saputo che c’era il mitico Piero da Maren, andò in camera e gli dedicò Bohemian Raphsody.
Piero parla nove lingue, ma ora dice di non ricordare i vocaboli. Un crescendo di esperienze che gli alieni di Bepy sembrano nulla al confronto.
Mentre Bepy e Piero si confrontano su temi internazionali: alieni, Kennedy, Freddy Mercury ecc. irrompe quasi dentro il bar Tonet con il quad. Sentendo gli argomenti del dialogo dice ai due amici:” voi due siete fuori con le carte”.
“Io la settimana scorsa sono stato rapito da un’aliena che voleva un figlio da me per poter migliorare la qualità della loro razza”.
E Bepy: “ereo per caso martedì?”
E Tonet: “sì proprio”.
Bepy: “Allora era la stessa astronave che ghe ho cambià el bueon mi”.
Tonet: “credo de sì”.
In un angolo c’è Bobo che si rolla una sigaretta alternando tabacchi che a tutti quelli che entrano dice “Ehi fratello rasta” ponendo le dita in segno di vittoria.
Faccio loro tre spriz con l’aperol e mentre li preparo penso alla bellezza della vita e a quanto queste persone, bollate come diverse da una società che ha bisogno di nascondersi dietro le false certezze della normalità, riescano in realtà ad alleggerire le mie giornate. Sono persone che vanno oltre i limiti che la società impone e ignorano le zavorre che ognuno di noi si mette addosso.
Forse per essere spensierati, in questa società pesante, bisogna essere un po’ diversi. Forse per essere liberi bisogna essere un po’ “folli”.
Alberta Bellussi