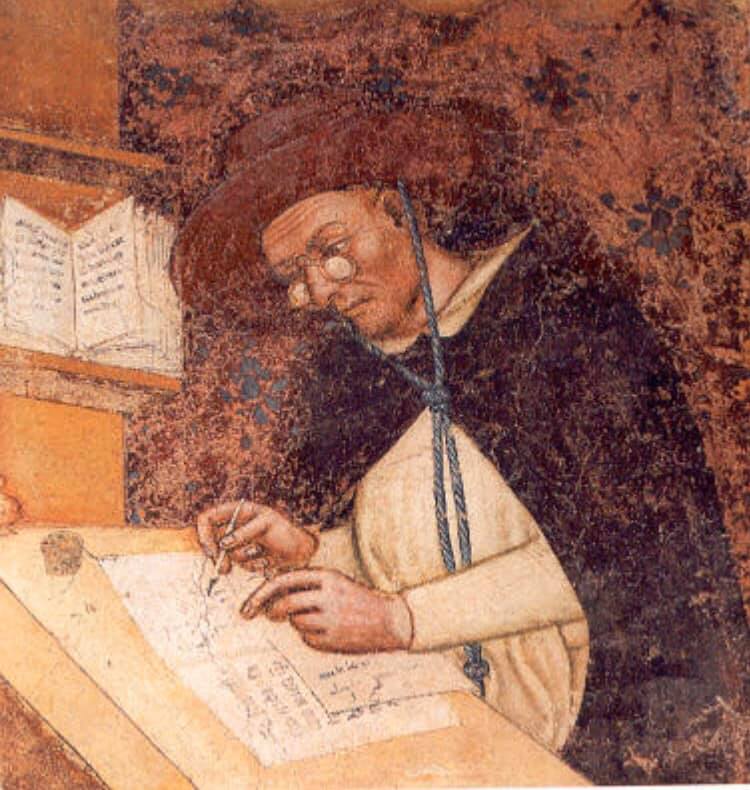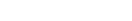Cara Veneto,
in questi giorni vedere Venezia, le spiagge, le isole, i paesi feriti fa soffrire anche me.
Pensare di vivere in Veneto mi ha sempre dato un enorme senso di protezione.
Mi ha sempre fatto sentire al sicuro.
Ho sempre pensato al Veneto come a un Paese forte, maschio, pieno di storia e bellezza che sa proteggere i suoi figli, che si prende cura di loro con amore e passione.
Ora ti vedo ferito nel tuo cuore perché Venezia è il cuore pulsante di questa Regione; è storia, bellezza, arte, sogno, poesia….è la meravigliosa eredità che ci ha lasciato 15 secoli di Repubblica Serenissima che ogni veneto porta nel DNA dal mare ai monti… appartiene a tutti noi. Se per questa tragedia soffre l’Italia provate a pensare il dolore che sta provando un veneto a vedere la sua città magica e fragile così profondamente ferita non si può nemmeno definire.
Ti vedo fragile e vulnerabile piegato alla potenza della natura che non perdona e alla superficialità dell’uomo che capisce il valore delle cose solo quando le sta perdendo.
In questi anni sei stato messo duramente alla prova in quelle eccellenze che ti rendono unico e con le quali hai affascinato e continui ad affascinare tutto il mondo: Venezia, le isole, le spiagge , le città, i paesi, i borghi, il Piave, i fiumi, i laghi, le Dolomiti…
Però sono certa che ti rialzerai presto e tornerai ad essere BELLISSIMO.
Perché tu sei tanto.
Sei di più.
Vivo in provincia di Treviso, in quel Veneto che da sempre è stato motore e traino della storia, della cultura e dell’arte ma soprattutto dell’economica del nostro paese.
Vivo nel Veneto dello splendore della Serenissima, di personaggi la cui genialità è conosciuta in tutto il mondo da Palladio a Canova, da Tiepolo a Tintoretto, da Tiziano a Canaletto, da Cima da Conegliano a Palma il Giovane.
Di Venezia del cui splendore e valore non si trovano parole nel vocabolario per definirla una città che ha forgiato il Veneto dal mare ai monti con lo splendore delle Ville, dei boschi del Cadore, dei palazzi, di una sacco di altre cose per cui mi ci vorrebbero pagine e pagine per definirla. Città generosa che regala a chi la sfiora, anche solo una volta nella vita, con lo sguardo emozioni che rimangono tatuaggi indelebili nel cuore e nell’anima. Il leone fiero e ruggente che ti simboleggia è ferito, umiliato nella sua potente fragilità;
di Verona e della sua splendida Arena; di Vicenza e il Palladio; di Rovigo e del suo legame con il Po; di Padova città del Santo; di Belluno e delle splendide Dolomiti; di Treviso piccola preziosa bomboniera tessuta dall’acqua .
Vivo nel Veneto di quei litorali ospitali e allegri.
Vivo nel Veneto delle Dolomiti che in ogni momento della giornata sono così belle da togliere il respiro…
Vivo nel Veneto delle piccole e grandi città d’arte, dei borghi, dei paesi con i campanili, delle colline, dei laghi, dei fiumi e delle splendide campagne.
Vivo nel Veneto del fiume Piave, dove i nostri avi hanno conosciuto la miseria, la distruzione della guerra e la dolorosa invasione del nemico.
Vivo nel Veneto primo in Italia per la raccolta differenziata, per le energie rinnovabili, per l’innovazione.
Vivo nel Veneto del volontariato, delle Pro Loco, delle sagre e del piacere dello stare insieme.
Vivo nel Veneto delle grandi aziende vitivinicole e gastronomiche, dei prodotti agricoli, dell’asparago, del radicchio, delle ciliegie, del formaggio e molto molto ancora.
Vivo nel Veneto degli orti, delle galline sul cortile, del maiale e della mucca in stalla.
Vivo nel Veneto delle case ordinate, dei giardini curati, dei fiori sui davanzali.
Vivo nel Veneto dei mille dialetti, delle tradizioni secolari.
Vino nel Veneto delle osterie a gestione familiare.
Vivo nel Veneto dei grandi ospedali e delle eccellenze mediche.
Vivo nel Veneto dei grandi campioni dello sport.
Vivo nel Veneto delle grandi fabbriche manifatturiere, delle grandi eccellenze dell’artigianato e delle grandi industrie.
Vivo nel Veneto delle piccole imprese, delle aziende a conduzione familiare, del padre che lavora con il figlio e con i nipoti.
Vivo in un Veneto di gente che meno di 70 anni fa era nella miseria, che con dignità coraggio e rispetto si è rimboccata le maniche e si è data da fare.
Vivo nel Veneto della gente che si alzava all’alba e andava a letto a notte inoltrata con l’orgoglio di lavorare per un progetto, per un investimento sul quale aveva creduto ma soprattutto per quel futuro certo da lasciare ai figli.
Vivo nel Veneto del miracolo economico.
Vivo nel Veneto di brava gente, gente onesta, gente con i calli nelle mani e le rughe in viso.
PER QUESTI MOTIVI SONO SICURA CHE IL VENETO TORNERA’ PRESTO AD ESSERE MERAVIGLIOSO E SUPERERA’ TUTTO CON LA GRANDE DIGNITA’ CHE APPARTIENE ALLA MAGGIORANZA DELLA SUA GENTE.
Un Veneto di gente che si asciuga le lacrime dello smarrimento e trova subito una soluzione;
un Veneto di gente coraggiosa che non si lamenta; un Veneto di gente che si alza le maniche e si dà da fare;
un Veneto di persone con grande cuore che aiutano il prossimo; un Veneto che con coraggio difende quello che ci appartiene, un Veneto che ha carattere, dignità, tradizione, cultura, storia, passione, amore.
È, ora, il momento per esprimere l’amore per la nostra terra, per confermare la nostra appartenenza, per aiutare quel Veneto ferito nel cuore, nella sua città unica al mondo, a rialzarsi e a riavere un futuro sereno.
Con amore immenso per Venezia e per il Veneto per tutto ciò che ci hai generosamente regalo che ha forgiato dal mare ai monti il nostro carattere…. Con la certezza che il leone ferito torni a ruggire della sua meravigliosa bellezza e splendore.
Alberta Bellussi