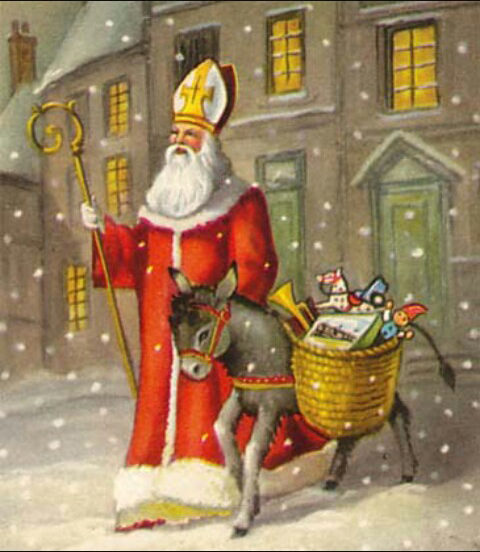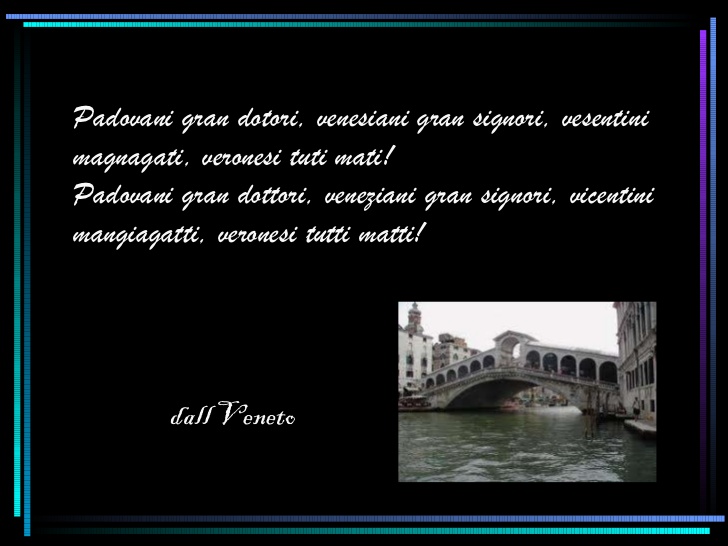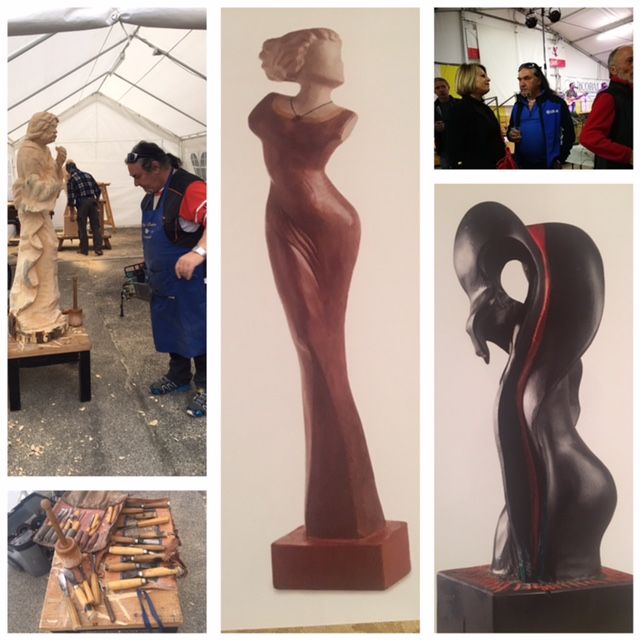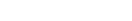Dicembre, Gennaio e Febbraio sono i mesi in cui in Veneto c’è la tradizione di macellare el porzel. E’ una tradizione secolare. Ricordo, quando ero piccina, che il giorno in cui si macellava il maiale stavo a casa da scuola ed era grande festa dalla mattina alla sera; c’era el porzeler che guidava le operazioni di divisione della carne quella per salami, salsicce, coppa, ecc ecc; partecipavano parenti, amici e tutto il giorno era un via vai di gente. Sopra la “cucina economica” c’era sempre qualche braciola o costina pronta per essere mangiata da qualche ospite o da noi bimbi. A me sembrava buonissimo. Osservavo tutto con occhi curiosi. Qualche adulto burlone ci mandava in giro a chiedere la forma per fare i salami e noi ci cascavamo…e quando si tornava a mani vuote tutti ridevano divertiti di averci burlato. Per questa prova dovevi passare per diventare un pochino meno credulone…
Nella nostra storia contadina il maiale era la principale fonte di proteine nell’alimentazione povera di un tempo insieme al pollame. Per assicurare una migliore conservazione delle carni da lavorare, la macellazione del maiale avveniva nel periodo piu’ freddo dell’anno, dicembre, gennaio e febbraio.
Nel mondo trevigiano il maiale è una sorta di rito della cultura contadina che ha la sua festa il 17 gennaio, giorno della celebrazione di S.Antonio Abate, chiamato anche S. Antonio del porzel perche’ viene raffigurato con un maiale ai suoi piedi.
Tradizione vuole, infatti che Sant’Antonio Abate, patriarca del monachesimo, venga rappresentato nell’iconografia sacra seguito da un maialino, popolarmente interpretato come l’immagine del diavolo ( a cui anticamente si associava il porco, creatura degli inferi) sconfitto dall’eremita. Ma la storia dice che si riferisca anche all’allevamento dei suini, inizialmente adottato dai monaci antoniani per dare sostentamento all’ordine ospedaliero dagli stessi fondato.
La macellazione del maiale era un momento di festa per tutta la famiglia e lo è ancora oggi, nelle famiglie in cui si rispetta ancora questa tradizione tutto viene svolto con lo stesso rituale di un tempo.
Subito dopo l’uccisione veniva ‘assaggiato’ cuocendone le ‘animelle’ (cervello e midollo spinale) e le ‘rifilature’, cioe’ i pezzetti di carne che si ottenevano lungo il taglio di sezionatura della bestia.
Del maiale non si sprecava nulla: le setole erano utilizzate per fabbricare pennelli, gli ossi venivano bolliti per fare brodo e sugo e la cotica entrava nella preparazione di ‘coppa’ e cotechini. Per il resto, le bistecche e le ‘costórelle’ alla brace, gli zampetti in umido (con i fagioli). La pelle, una volta tolto il lardo (unico condimento adoperato per tutto l’anno), serviva per ungere le seghe. Col sangue si faceva il sanguinaccio e con i polmoni una specie di salsicce. Il grasso del sottoventre era utilizzato per la profumata zazieka, mangiata a colazione con la polenta.
Mai fuori moda gli ossi di maiale lessati che vengono preparati ancor oggi da ristoranti, trattorie ed osterie venete chiamati Ossada.
Ricetta dell’Ossada de porzel
Ingredienti:
1 kg. e mezzo di ossi di maiale freschi (ossi spolpati, arista spolpata, costine)
1 cipolla
1 gambo di sedano
2 carote
grani di pepe
alloro
sale
Preparazione:
Lavare tutti gli ossi e prepararli per la cottura, tagliando i pezzi più grandi. Mettere in una pentola capiente con tutte le verdure e il pepe in grani. Portare ad ebollizione e cuocere per almeno un’ ora.
Devono essere serviti caldissimi, spolverizzati con il sale e un filo di olio, con le verdure di cottura.
Alberta Bellussi
- 18 February 2018
- No Comments
- #maiale #festa #veneto